Ma voi sapevate che il compianto Paolo Villaggio scriveva aforismi? Che Woody Allen ne ha scritti di bellissimi? Per non parlare di quelli di Borges, Wilde, Kafka, Baudelaire, tornando indietro nel tempo e passando in rassegna alcuni autori che hanno lasciato la loro enorme impronta nella storia della cultura occidentale e mondiale di ‘800 e ‘900.
Di scrittura aforistica, quella che in brevi frasi condensa delle massime passate alla storia come momenti di saggezza o schegge di cultura proveniente dalla più diversa estrazione, ce ne parla Marco Ongaro alla presentazione scaligera del suo ultimo libro Guida ai grandi aforisti edito dalla casa editrice bolognese Odoya. Lo scrittore veronese, da anni parigino d’adozione, ci porta alla scoperta di questa forma d’arte attraverso la geniale condensazione di ventidue saggi in uno. Ventidue autori raccontati in un’antologia di duecentocinquanta pagine che coinvolgono il lettore con riflessioni e spunti proposti dalle tante frasi prese in esame. Frasi divenute iconiche, raccontano di amore, politica, filosofia, veri spaccati della società del tempo in cui sono state scritte. Comune denominatore è l’accezione letteraria di partenza per ciascuno dei ventidue giganti esaminati, in realtà immense figure dalle personalità polimorfe.
“In una breve frase spesso si possono condensare intere visioni della vita, pillole di poesia o riflessioni universali serie, ironiche, satiriche, pronte a cogliere le diverse sfumature umane” scrive Marco Ongaro e nella estemporanea intervista che mi onora di fargli alla sua presentazione, io in qualità di improvvisato relatore e improvvido conferenziere in jeans e camicia rosa confetto, lui aggiunge: “L’aforista per la sua tendenza a essere folgorante nei giudizi e nei commenti, fornisce materiale di prima mano a chi nei post sui social edifica la propria personalità mediatica sulle fondamenta della moderna frenesia citazionistica”. Niente di più vero, penso subito. Tutti noi ci possiamo cimentare nello scrivere dei buoni aforismi, “come è vero che alcuni di quelli che sono stati scritti dai grandi del passato possono risultare leziosi e non per forza indottrinanti” chiarisce in sala l’autore del testo. Ma allora che cosa consacra un aforisma nella storia ce lo spiega lo stesso autore attraverso una funambolica dissertazione iniziale dove alla fine “a vincere è l’Album”. Certo, si fatica non poco a cogliere tra le righe di Ongaro tutti i messaggi che ci vuole trasmettere. Una imponente valanga di concetti che è bene sottolineare per poi sbrogliarne alla fine la matassa dei molti saperi trasmessi e sedimentarne i contenuti. Ma la piacevolezza che si trae dalla lettura di questa “Piccola antologia di grandi aforisti” (già dalle prime ventuno pagine) ripaga ampiamente dello sforzo.
“A vincere è l’Album”? Lo scrittore prende spunto dalla teoria dialettica tra Album e Libro del francese Roland Barthes. Il filosofo e sociologo del linguaggio, vissuto tra il 1915 e il 1980, considera il Libro concepito e organizzato intenzionalmente e l’Album inteso come raccolta casuale di ispirazioni ed epifanie senza una precisa intenzionalità organizzata. L’uno dal corpo ragionato, l’altro dalle sembianze frammentate. Ecco chi vince la sfida. Se il Libro è il risultato inconfutabile, concreto di varie annotazioni, idee, osservazioni, raccolte in Album durante la fase della preparazione, inaspettatamente quelle idee raccolte torneranno un giorno libere di veleggiare distaccandosi dalle macerie dello stesso libro. Insomma, torneranno alla loro naturale e nuova condizione di Album. “Del libro rimane dunque la citazione, la frase memorabile che ha letto noi nel momento in cui la si leggeva” continua Marco Ongaro “il nuovo Album di un individuo, di una cultura, di una società è formato da ciò che ha prevalso nel mare magnum della scrittura”. Le rovine sopravvivono ai cambiamenti delle epoche che si succedono. L’aforisma, si accennava, è per definizione una sentenza o massima che riassume in brevi parole un concetto filosofico o una regola di vita e si distingue dall’apoftegma rappresentato da sentenze memorabili e massime brevi, argute. E se il modo di scrivere scelto è quello che si affida alle massime come scheletro su cui costruire la propria opera, risulta evidente che “L’aforisma è la memoria di un pensatore, l’apoftegma è l’arguzia di un comunicatore”. Comunque sono entrambi fotografie ricordo di una scrittura ormai sommersa, ci racconta il nostro narratore. E l’aforisma è dunque forma d’arte sintetica ed efficace che meglio rappresenta lo scrittore scomparso, sancendo definitivamente l’effettiva vittoria dell’Album sul Libro.
Tra le altre interessanti intuizioni contenute nell’opera, anticipate verbalmente al pubblico, spicca quella di un importante pensatore, poi trattato individualmente. Theodor W. Adorno specifica che i suoi aforismi “vogliono segnare punti di attacco o fornire modelli per un futuro approfondimento del concetto filosofico”. Ne segue la precisazione del contemporaneo Baricco “Anche quando si atteggiano a sentenze definitive e perentorie quel che fanno è inaugurare la riflessione: mai concluderla”. Ma, ci spiega Ongaro: scrittori e artisti, scienziati e pensatori ancor prima di ambire a trasmettere il loro pensiero sono i primi a citare per prendere spunto e alla fine modificare nell’intento futuro di creare ex novo. Chi avrà rubato cosa all’altro? L’autore di questo libro dà una risposta precisa: “Questo genere di pensieri migra di cultura in cultura con rapidità superiore all’immaginazione, grazie alla sua facile trasportabilità” e ancora “È impensabile pretendere di giungere alla fonte primigenia della citazione. È già molto essere in grado di rammentare l’ultimo pronunciatore di una massima, l’ultimo divulgatore di frasi antiche e concetti memorabili”.
Nel prosieguo della presentazione, orgoglioso per le mie domande da relatore impreparato all’evento ma con l’apparente dignità di chi non lo dà troppo a vedere, intuisco sempre più di essere in difetto stando al fianco dell’eclettico Ongaro. Sui social media, un mondo a me sconosciuto fino a qualche mese fa, uso anch’io degli aforismi altrui oltre ai pochi e umilissimi miei medesimi. Su consiglio della mia valente web strategist che me li ha venduti, per l’occasione, con il nome inglese meme (sapevo che dovevo fidarmi del mio intuito e che quella definizione non mi piaceva). Fatto sta che il dissertatore pone l’attenzione sulla naturale pulsione umana a costruirsi un Album per rappresentare se stessi. Magari per strappare più “Mi piace” possibili. Una sorta di dimmi chi citi e ti dirò chi sei, dimmi chi conosci e io saprò se ammirarti o trascurarti. Mi rincuora solo ciò che Ongaro cita poi nel libro “Ciò che avviene quotidianamente sui social non è che un’istanza collettiva già ben affermata su carta”. Insomma, il pericolo è quello di costruire con la farina del sacco altrui il proprio microcosmo.
I corrosivi aforismi “Quanto poco c’è da fidarsi di una donna che si fa cogliere in flagrante fedeltà. Oggi fedele a te, domani a un altro” di Karl Kraus e “L’Italia è un Paese dove sono accampati gli italiani” di Ennio Flaiano o il più compunto “Ho avuto una giornata massacrante. Ho passato la mattina a cercare di togliere una virgola e l’intero pomeriggio a cercare di rimetterla” di Oscar Wilde sono solo parte della risposta di Ongaro alla specifica domanda della bella e brava lettrice ufficiale della serata: gli aforismi sono sempre umoristici? L’autore ci porta magistralmente a riflettere su altri due esempi, citando il sarcasmo di Roland Barthes “La guerra contro l’intelligenza viene sempre condotta in nome del buon senso” oppure riflettendo sull’amarezza di Charles Baudelaire “Le nazioni hanno grandi uomini a loro dispetto”. In altre parole: niente da ridere, tutto da comprendere. E qui sta il punto. L’umorismo può essere aforistico, l’aforisma non necessariamente è umoristico. Può essere comico, arguto, satirico, filosofico dipende dallo stile dell’autore e dal suo approccio al mondo. Starà all’abilità dell’aforista far cadere le sue trovate in mezzo a un testo più lungo oppure a inanellarne una serie quando lo riterrà opportuno.
A conclusione, Marco Ongaro rimarca ancora l’aforisma come una verità enunciata con la forza della brevità. Il carattere di sentenza che ne consegue dà all’aforisma la credibilità che intere pagine sullo stesso argomento non potrebbero garantire e dà allo scrittore immortalità apparente. Il pensiero si trasferisce dalle pagine o dalla vita dell’aforista all’Album della cultura che ancora ci accompagna.
Sono le undici di sera. Si è fatto tanto tardi in questa biblioteca e ora mi affido a Virginia Woolf: “Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è cenato bene”.
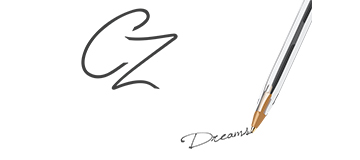








Leave a Reply