Ai tempi del Covid-19 il piacere di incontrarsi si può trasformare in un incubo, mi assicurano tutti gli amici e le amiche single. C’è chi abbraccia trattenendo il respiro, il bacio è ormai un lontano ricordo, chi si cimenta in rapporti sessuali alternativi corredati di FFP2 e di una edizione tascabile del Kamasutra. Eros e amore sono minacciati dal virus e dal suo paradosso: la trasmissione avverrebbe più nella prossimità tra i corpi che per via sessuale. E se autoerotismo e sesso virtuale sembrano le vie più asettiche e consolatorie per contrastare il virus, per l’amore maiuscolo, quello “vero”, serve ancora più precauzione e fantasia.
Eppure l’amore è un tema immortale. Se ne scrive da sempre e si continuerà a farlo. Difficile pensare di poter aggiungere qualcosa di nuovo all’argomento. Tuttavia, riflettere sulla relazione tra Eros e Amore proposta da alcuni pensatori del nostro tempo può offrire nuove idee, spronare a riflessioni. Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, Massimo Cacciari: punto di partenza per tutti è il Simposio di Platone, l’importante opera dell’antico filosofo greco dedicata al tema dell’amore (eros – ἔρως).
In questo dialogo, scritto nella maturità di Platone e che fa parte dei dialoghi socratici, si parla della celebrazione di un banchetto durante il quale ognuno dei partecipanti espone la propria idea sull’amore. Discorsi che vanno dal più superficiale al più profondo e conclusivo di Socrate, che poi rappresenta il pensiero di Platone l’erede autentico di Socrate. L’amore è presentato, secondo il mito, come un demone, figlio di póros (risorsa) e penía (povertà), partecipe quindi della natura di ambedue: non ha la bellezza, ma la desidera, non ha la sapienza, ma aspira a possederla.
Fedro parla per primo e sottolinea che Eros, il dio greco dell’amore, è il più antico degli dèi e rappresenta la forza ispiratrice per azioni grandiose e che è l’amore il mezzo mediante cui migliorare. Pausania parla di amore corporeo, superficiale e più fisico, e amore celeste, legato alla perfezione morale. Aristofane propone una origine mitologica dell’uomo. In principio c’erano tre tipi di esseri: uomini, donne, androgini. Per la loro tracotanza e ambizione gli androgini furono divisi in due da Zeus al fine di renderli più deboli ed evitare che attentassero al potere degli dèi. Ma da questa divisione nasce negli umani il desiderio impossibile di ricreare la primitiva unità. Zeus, allora, per evitare l’estinzione degli uomini manda nel mondo Eros. Eros perché li aiuti a ricostruire l’unità perduta e attraverso il piacere del ricongiungimento e la riproduzione potersi dedicare alle altre incombenze che devono svolgere. Socrate conclude parlando dell’amore come la forza che conduce alla contemplazione della bellezza più pura e ideale. L’idea della bellezza costituisce il termine ultimo dell’ascesa dell’eros: “Bellezza eterna, che non nasce e non muore, non s’accresce né diminuisce.”
Elevandosi fino all’idea, l’eros consente il passaggio dall’ignoranza alla scienza. Per Platone le idee sono realtà invisibili, stabili, sempre identiche a sé stesse e l’anima è capace di coglierle solo in quanto è simile al “divino e all’immortale”. Per il filosofo il rapporto fra l’anima e le idee non si esaurisce nella sola conoscenza intellettuale, ma investe tutt’intera la vita dell’uomo. Lo mostra proprio il Simposio, dedicato al tema dell’amore (eros).
Riporto alcune riflessioni espresse quest’estate dai tre pensatori intervenuti in Arena.
MASSIMO RECALCATI
La bellezza è il luogo della luce. La luce rende possibile lo splendore del mondo, viene dalla Bibbia. Ma nella dimensione degli amanti la luce si trova nello sguardo. E non solo nel microcosmo delle coppie, ma anche in quello dei genitori. La luce negli occhi di un figlio, la luce negli occhi del maestro. Dove c’è luce non è solo il corpo, ma l’effetto di far nascere il mondo di nuovo. Il mondo nasce di nuovo. Prima di incontrarlo il mondo era grigio, nelle tenebre.
Il mondo nasce di nuovo. La potenza della luce, dell’illuminazione. Anche la voce può essere luce nell’amore, nell’incontro. Di cosa mi sono innamorato? C’è lo sforzo di capire la qualità dell’oggetto amato. Ogni elenco si disfa, è insufficiente. Andiamo verso l’esistenza dell’altro! Cosa amo dell’altro? È il suo modo di stare nel mondo, amare anche i difetti.
La tua esistenza fa splendere in modo nuovo, il mio modo. Amiamo tutto dell’altro, amiamo la sua esistenza che per me è diventata insostituibile. L’amore rende impareggiabile l’amato o l’amata. L’amore che dura è amare imperfezioni e psiche. Gli altri amori non durano e accadono per caso, sono amori imprevedibili, il puro caso. Rendere il caso nella forma del destino è la gioia dell’amore. Trasformare il caso nel destino. La mia vita trova un senso. L’attesa è una grande gioia dell’amore. L’essenza dell’amore è sentire che la mia esistenza mancava. L’attesa è una grande gioia, qualcuno si accorge di me e del mio ritorno.
L’esperienza del lutto fa spegnere la luce e il dolore che proviamo è insignificanza della nostra vita. Prende forma una situazione depressiva: non manco più a nessuno. La bugia dell’amore romantico e idealistico viene dal simposio di Platone. L’amore, secondo il mito di Aristofane, indica i 3 tempi della natura umana dal principio:
- Esseri cilindrici a due sessi, autosufficienti, arroganti e che tentano l’assalto al cielo
- Zeus di fronte all’assalto li taglia a metà e osserva i due cilindri che soffrono la separazione
- Pietà sulle parti scisse e dolenti. Zeus chiama Eros perché si metta a caccia dell’intero per ricostituire l’essere che eravamo
La grande menzogna è completare il mito dell’unificazione. Il miraggio di totalizzazione genera gelosia, sopraffazione, fuoriuscita dal mondo, isolamento. Non siamo due parti di una stessa mela. Liberiamoci dall’idea romantica dell’amore. La simmetria genera violenza. La condivisione è irraggiungibile, bisogna amare “l’incondivisibilità”.
Platone vorrebbe riunire il corpo, le due unità: amore come desiderio di unità. Questo fino a Philip Roth che lo contesta: non è riunendo il corpo, non è con la ricostituzione dell’intero che arriviamo all’amore. Anzi, l’amore spacca e frantuma: l’amore come distruzione dell’unità. L’esistenza dell’altro provoca la mancanza e devo amarlo, l’altro, per uscirne. L’amore ci rende mancanti. In che modo l’amante vuole essere l’amato? Voglio che lei sia mia. Ma cosa mi serve se la precludo in casa? Vivere il paradosso del [totalmente liberi, ma prigioniera mia] è contraddizione in termini. La violenza è una degenerazione di una spinta “appropriativa”. La violenza è al posto del lutto. Ma l’amore che si fonda sulla libertà assoluta dell’altro rischia la perdita dell’altro. Violenza, contraddizione e profanazione dell’amore. Differenza tra amore e desiderio sessuale. Freud dice che amore ed erotismo sono disarmonici. Il desiderio erotico deve garantire resistenza alla coppia. Ma secondo la più recente psicologia americana gli innamoramenti hanno i tempi contati, 6-18 mesi, a causa della Dopamina [l’ormone del piacere e della ricompensa N.d.R.]. È il disincanto freudiano. Diamoci la possibilità di oltrepassare la rigidità: l’amore dura o brucia. Coinvolgiamo Ungaretti: l’amore che dura è la quiete che dura. Che qualcosa resti acceso, l’erotismo permanente. Dobbiamo riformulare la nostra rappresentazione del tempo dell’amore: maledizione del tempo e stemperamento della luce. La rappresentazione ordinaria non va bene. L’estasi del primo incontro, del primo sguardo non terminino. Devono seguire altri primo sguardo. Quindi non degradazione, ma rinnovare l’origine. Trovare qualcosa di nuovo. Il nuovo primo sguardo che c’è dell’inesauribile.
UMBERTO GALIMBERTI
L’Amore a partire dal Simposio di Platone.
Se io ti do il mio amore, cosa ti sto dando? L’amore dispone dell’Io, l’amore non è faccenda dell’Io ce lo ha spiegato Freud per primo. Gli amanti non stanno insieme per la passione carnale. Platone ci ha insegnato a parlare secondo principi di contrapposizione e casualità. Momento creativo ed erotico appartengono alla follia e quindi agli dèi. Distanza tra gli dèi che abitano scenari della follia e uomini che abitano scenari della ragione. Noi teniamo bada alla nostra parte folle, ma a volte collassiamo con l’ebbrezza e l’amore. Se vuoi parlare d’amore devi dislocarti dall’Io.
Nel simposio di Platone, Socrate si trova a casa con Aristofane. Socrate (sono il filosofo che non sa niente, ma qualcosa so) fa intervenire la dimensione femminile [Diòtima racconta a Socrate della nascita di Eros, in seguito a un incontro avvenuto a un banchetto in onore di Afrodite. Qui un uomo ricco di nome Póros si unisce a una donna povera di nome Penía, che del pranzo riceve solo le briciole N.d.R.]. Uomo = logico matematica; Donna = logica matematica + logica sentimentale e intuitiva. Quando i due parlano con un linguaggio duale capiscono parole comprensibili solo a loro. Donna parte femminile dell’uomo. Le due soggettività sono aggressività (difesa) e amore. Platone fa nascere Eros dalla povertà. Amore è mancanza. Non desideriamo ciò che abbiamo, desideriamo ciò che manca ed è quello che stimola la nostra vita per uscire dalla mancanza, cercare la via d’uscita. Amore non è possesso.
Platone fa di Socrate quello che racconta, intrappolato tra due estremi: umani e dèi. Il sogno è dimensione della follia. Amore è l’intermediario tra parte razionale e folle, tra umani e dèi. Amore fa da intermediario con l’innamoramento. Amore non è fra me e te. Amore è affidarsi quando ti ha catturato la mia follia e dando fiducia posso uscire quando voglio. L’amore è immersione nella propria follia e dopo che è stato immerso nella propria follia l’Io è diverso. Ogni storia d’amore trasforma il nostro Io. Collasso dell’Io. Tutte le storie d’amore trasformano l’Io e la condizione della vita. Alla fine del Simposio interviene Aristofane: gli uomini erano rotondi con 4 braccia e 4 gambe affacciati l’uno all’altro, non l’uomo singolo. Zeus ordinò ad Apollo di tagliare questi esseri a metà. L’uomo è un simbolo di un uomo e non uomo intero che Zeus ha diviso. La cena si conclude nel simposio con tanto vino. L’amore non è figlio del vino. La follia genera la creatività.
MASSIMO CACCIARI
Il rapporto tra pensiero filosofico ed Eros è figura originaria. Nel Simposio di Platone Eros è principale come problema. Dal punto di vista filosofico qual è il significato culturale di Eros? Eros ha etimologia sconosciuta. Si pensa che non abbia origine indoeuropea, ma mesopotamica. Eros potrebbe richiamare queste antiche civiltà. Eros è una divinità ingenerata che non ha figura. Altre divinità sono nate e devono morire. Nella Teogonia di Esiodo ci sono degli dèi causa di tutti ma non generati:
CAOS: l’apertura
GAIA: la sede di tutti gli eventi che accadranno o che arriveranno
TARTARO: la sede sotterranea
EROS: non ha figura come gli altri
Esiodo [il poeta più antico della Grecia continentale N.d.R.] definisce Eros come colui che discioglie le membra. Eros è sovrano di tutti gli dèi, dio ingenerato cui nessuno può sottrarsi. Non ha radice, è radice. La potenza è irresistibile. Grande dio ingenerato, più grande di tutti gli dèi assieme agli altri 3. Eros + Caos + Gaia + Tartaro. La filosofia dice che Eros manca di qualcosa e lo distrugge definendolo demone, un intermediario tra uomo e Dio. Platone dice che Eros non ha casa, tende sempre all’amato e quindi è nostalgico. Eros accompagna l’amante per ricongiungersi con l’amato, ma ha nostalgia e quindi è debole, è demone. Gli dèi dimorarono, Eros non ha dimora, ma Eros ci muove e muove la filosofia. Non è Eros-Sophia, ma Filo-Sophia ovvero amici della Sophia senza turpi desideri. La figura erotica immaginaria diventa colui che ci spinge verso turpi desideri. La filosofia ci rende amici della filosofia, ma per avere sapienza è utile chi ci accompagna verso la Sophia senza Eros, non più come passione ma come amicizia che razionalmente ci avvia verso il Sapere (che Platone chiama il bene). Se educato è un buon demone, Eros. Tirato fuori dalla dimensione passionale e distruggitrice con cui era apparso nella mitologia originaria e nella lirica, Eros è Philia (amicizia). Eros guida razionalmente verso il sapere ultimo. Infatti, il filosofo non potrebbe portare a termine la sua navigazione senza l’impeto di Eros che conduce a “osare”, “rischiare” e avventurarsi anche nel mondo delle idee e dei principi sommi. Attraverso un itinerario di conoscenze. E Platone lo sa che è difficile osare tutto. Come si combina osare tutto senza Eros, impeto erotico? Platone sa bene che c’è una mania divina che supera l’intelletto e tra queste c’è la mania erotica che viene dagli dèi. Non è possibile fare a meno della potenza di Eros, dice Platone. Tensione amato-amante: come la pensiamo? L’amante vuole entrare nella casa dell’amato come il filosofo vuole congiungersi con la Sapienza.
Ci sono due modi.
Primo modo: la congiunzione di amante e amato che diventano uno. Ma ci vuole una mania, eccedere la dimensione della mente. Eccedere tutto per ricongiungersi con l’amato. È un passo violento contro tutto ciò che è normale. Enosis
Oppure
Secondo modo: la congiunzione di amante e amato è un uguagliarsi e non un essere unico. Un movimento di approssimazione. Non enosis, ma omoiosis. Ovvero essere uno è un compararsi e anche qui ci vuole la potenza di Eros. Non una potenza violenta che ci fa eccedere. Ci facciamo prossimi, ma nel differire. La nostra straordinaria forza della psiche è quella che ci fa essere un tutt’uno con l’altro che amiamo. OMOIOSIS. Assomigliarsi nel differire. Il timbro dell’amore che si custodisce nell’ambito dell’intelletto. Amando l’altro pur essendo coscienti di non poter amare l’altro come Dio. Siamo Dio. È il concetto limite tra amato e amante. Mai il mio amore può essere come l’amore di Dio. Come ama Dio? Amore senza scopo, non come l’Eros di Platone. Dio ama donando in modo disinteressato. E questo per noi, per il nostro amare, è impossibile. Come può l’uomo identificarsi con l’Amor Dei?
L’eterno amore si apre in nuovi amori a sua immagine, come è per lui. Amori liberi, incondizionati, amori simili al suo e non amori costretti. Abbiamo in noi OMOIOSIS? Che vuole altrettanti amori liberi e incondizionati? Se io amo per essere amato: è uno scambio, non è un amore. L’ amor intellectualis può aprirsi ad altro amore e avvicinarsi all’Amor Dei senza excessus mentis. L’amor intellectualis è l’opposto della passione dove ci vuole Eros che si combina con l’intelletto. Che non è passività. È attività, non costringendoci a nulla, ma rendendoci massimamente attivi come l’Amor Divino che ci ha liberato. Non c’è enosis, rimane quel differire.
L’estrema vicinanza è anche omologa con l’estrema lontananza. Perché la distanza dell’amato non verrà mai colmata, pena la sparizione della libertà dell’amato. “Nuovo amore come è il mio, se venisse colmata la differenza”. Lo dice Dante al cambio guida di Beatrice con San Bernardo nell’ultimo tratto del viaggio in Paradiso [Quanto lì da Beatrice la mia vista; ma nulla mi facea, ché süa effige non discendea a me per mezzo mista. Paradiso, XXXI, vv. 76-78 N.d.R.].
Beatrice e Dante, nel differire l’amore è più forte. Vicinanza e lontananza mantengono e custodiscono in sé e si aprono in nuovi amori. Sistole e diastole.
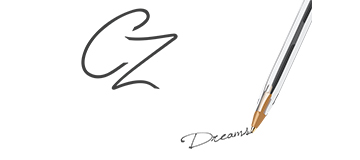
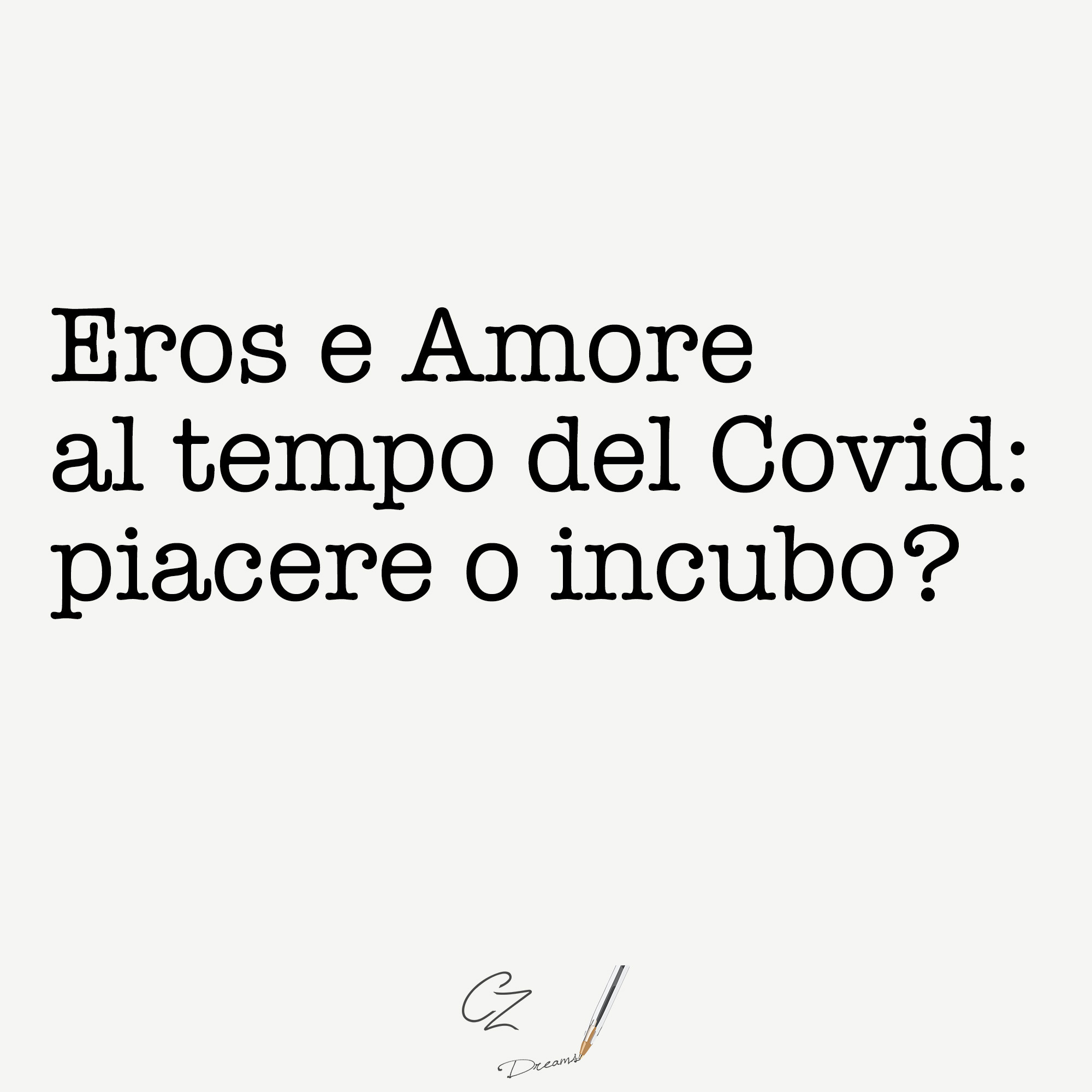







Leave a Reply