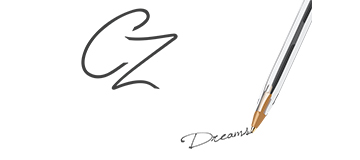Intervento di Umberto Galimberti al Festival della Bellezza 2021
Il filosofo, accademico e psicanalista italiano Umberto Galimberti non ha bisogno di presentazioni. Si può anche prendere gioco della platea del Teatro Romano, insultandola con eleganza per la presunta ignoranza che percepisce all’olfatto standosene in piedi per tutta la lunga dissertazione. Gli equivoci dell’anima sono una riflessione filosofica sulla genesi e l’eclissi dell’anima. Il dualismo anima e corpo fu proposto per la prima volta da Platone: la parola che lui utilizzò, “Psychè”, significa respiro vitale, nel senso di mente come di anima. Galimberti sottolinea che il termine è stato introdotto nella tradizione giudaico-cristiana solo successivamente da Agostino. Anima che resiste alla forza dissolvente delle passioni umane, anima come unica depositaria contro l’inganno dei sensi, sosteneva Platone. Agostino si appropria del concetto del discepolo di Socrate e introduce l’idea di salvezza abbinata all’anima. L’anima si spinge fino ai confini di una speranza ultraterrena. Per il greco antico il finito è perfetto perché compiuto (gente seria i greci antichi, ci confessa il professore) e ogni cosa raggiunge con la morte il suo fine e la fine. Ma la concezione agostiniana del tempo non è più ciclica, è escatologica, ossia riguarda i destini finali dell’uomo e dell’universo. Al concetto di tempo greco, visto come tempo della natura, Agostino sostituisce il concetto di tempo della salvezza cioè il tempo dell’uomo e della promessa di Dio che si concretizza alla fine del tempo, all’ultimo giorno, adempiendosi ciò che all’inizio era stato promesso. Il tempo diventa la costruzione di un evento salvifico. “Ma voi le sapete queste cose? Vi interessano? Riuscite a capirmi? Sono anni che predico questi concetti, ma vedo che non vengo ascoltato, sono stufo di parlare al vento e qui al Festival della Bellezza non ci volevo venire, poi gli amici organizzatori mi hanno convinto”, ci dice Umberto Galimberti tra il serio e il faceto. Poi aggiunge: “Quando pregate con il Credo, voi cristiani, lo sapete almeno che esprimete la vostra convinzione nella risurrezione dei corpi e non dell’anima? Questo dell’anima è un concetto che Agostino ha ripreso e introdotto nella dottrina cristiana solo quattrocento anni dopo Cristo, creando la grande beffa per il Cristianesimo che crede ancora nel ricongiungimento di anima e corpo dopo la morte. Ma la religione cristiana non ha nessun rapporto con l’anima. La religione cristiana è una religione del corpo, dell’incarnazione. La trascendenza viene accantonata, a differenza dell’islamismo o dell’ebraismo, le altre due grandi religioni monoteiste. Perciò nelle chiese troviamo l’iconografia dei corpi, mentre nelle moschee e sinagoghe troviamo scritte bibliche o coraniche senza immagini. “Ci siamo? Qualcuno di voi mi ha capito?”
Appunti di viaggio (dall’intervento di Umberto Galimberti al Festival della Bellezza 2021 – Teatro Romano, Verona)
La filosofia
La filosofia non sa niente.
I dotti, i grandi sono quelli che non sanno niente.
La filosofia non sa niente e ancora prima c’erano i sapienti nella Grecia antica. Chi ama il sapere è Platone, con lui nasce il pensiero (Poros).
Filosofo è l’atteggiamento di chi mette in pensiero idee che ha in testa “perché ha quelle idee lì”. Spesso per fede, perché sono le idee di una persona di riferimento. Socrate dice che è fuffa. Abbiamo idee senza fondamento nelle opinioni, abbiamo opinioni fondate su condizionamenti. Solo idee ben argomentate senza epistemi. La filosofia dovrebbe invece mettere in questione idee, metterle in discussione e continuamente alla prova.
Anima e corpo.
L’anima non esiste. La tradizione è nata con Platone, con la grecità.
La tradizione giudaica e cristiana c’è solo nella cultura greca, dove soma respira l’ultimo soffio (Ànemos) che esala la psiche. Tuttavia, non sempre, perché soma e psiche sono parole che non esistono in Omero, Esiste solo il corpo. L’ira sui proci è espressa con il corpo, che è subito espressione per Omero. Con Platone appare l’Anima. Non possiamo stabilire attraverso sensazioni del corpo ma su cose astratte e così Platone la chiama Psychè.
Anima: per questo motivo abbiamo distanza con il mondo orientale, che è più pratico. La ragione è un sistema di regole invertite della logica, secondo la lingua astratta inventata da Platone con i principi di non contraddizione. Mentre il bambino ragiona con il pensiero concreto e non riesce ad astrarre come gli adulti. Poi con l’età della ragione i bambini diventano tristi perché non c’è una pluralità di significati. Nella verità è il bambino, perché senza il principio della ragione non potremmo prevedere i comportamenti.
Se noi parliamo con logiche lo dobbiamo a Platone. Anima e corpo è concezione dualistica. Non essendoci nell’antico testamento, l’anima, i figli pagano la colpa dei padri. Nel nuovo testamento è il corpo. Tra cultura greca e giudaico cristiana c’è diversità, per i cristiani tutto è corporeo. Platone inaugura il dualismo. Agostino riprende da Platone e si crea una città caduca e una celeste perché l’uomo rifiuta la morte. Consolazione per noi uomini è la resurrezione dei corpi e la non mortalità dell’anima.
Il cristianesimo è cultura della speranza e fede mentre quella greca è tragica. Dante pensa come Platone perché crede nell’immortalità dell’anima e così il Cristianesimo ha vinto sulla grecità. Dobbiamo pagare di essere nati rispetto ad altri che non lo sono e quindi moriamo. Nella cultura cristiana non c’è più tragedia come nella cultura greca perché c’è la speranza dell’anima, crisi dell’adolescenza e visione del mondo.
Il corpo è follia, concetto svincolato per Platone. Più l’anima prescinde dal corpo, più è pura. Il corpo della donna è diviso da quella dell’uomo. Cartesio suddivide la realtà in res cogitans e res extensa. Con res cogitans s’intende la realtà psichica, cui Cartesio attribuisce le seguenti qualità: inestensione, libertà e consapevolezza. La res extensa rappresenta invece la realtà fisica, che è estesa, limitata e inconsapevole.
Corpo = sommatoria di organi → nascita della medicina: non è ciò che sento, ma come lo percepisco. Percepisco l’organismo non il corpo. Il corpo è deciso dal momento della vita. Cartesio inaugura la medicina scientifica l’anima si dissocia dal corpo. Allora nasce una scienza nuova, l’anticamera della psichiatria, che si chiama morbus sine materia, malattia senza riscontro organico. Nasce la psichiatria, medicina dell’anima. Anche l’anima si può ammalare. Comprendere è comprendere il centro del delirio. Poi arriva Sigmund Freud che dà una mano alla psichiatria.
L’isteria non mente vorrebbe quello che non potrebbe avere. Schizofrenia → causa – effetto. Dialogo: le convinzioni non verificate non sono libertà, basti pensare all’attuale tema delle vaccinazioni con le più assurde e svariate tesi no vax. L’individualismo dei cristiani si concretizza nella salvezza individuale dell’anima. Quello che conta è la salvezza dell’anima non della società. L’individuo è messo al vertice, mai la società.
Nel ‘900 ecco la nuova visione dell’uomo. La divisione anima e corpo è un cancro che porta alle malattie psicosomatiche.
La fenomenologia racconta le cose come si manifestano non come le raccontiamo. Il rapporto corpo – psiche cambia il rapporto corpus – mundi. È il corpo che registra il tempo al mondo che mi cattura o da cui voglio uscire.
I cristiani sono mortali, si fa fatica a morire, è il congedo dall’amore.
Siamo davvero sicuri che tutti i liberi pensatori del nostro tempo ci possano migliorare con le loro dissertazioni? Che i vari tuttologi, opinionisti, critici, filosofi, musicisti possano realmente avvicinarci alle sfere celesti, chiarendoci dubbi che nemmeno i più preparati gesuiti sono riusciti a dissipare ai propri fedeli e forse a se stessi in centinaia di migliaia di anni?